Oggi sento di condividere con voi qualcosa che, ancora adesso, mi fa battere il cuore: la nascita di Cieli in Fiamme, il libro che ho scritto a quattro mani con il pioniere Erich von Däniken. Due anni di lavoro, chilometri macinati tra il Piemonte e Interlaken, ore passate nel suo studio circondato da scaffali stracolmi di diapositive, pergamene, fotografie scattate quando molti siti erano ancora incontaminati. Oltre due anni di emozioni, letteralmente: ogni capitolo ha l’odore della carta antica e l’eco delle nostre chiacchierate serali.
Ho deciso di raccontarvi com’è nato il progetto, cosa troverete tra queste pagine e perché è un testo “centrifugo”, capace di uscire dai miei confini abituali per abbracciare il fuori: dal Bhāgavata Purāṇa alle lamentazioni sumero-accadiche, dai Dogon alla fisica quantistica embrionale delle Upaniṣad..
Dall’idea al manoscritto: un laboratorio emozionale
Tutto è cominciato con una telefonata di Elisabetta, la colonna portante senza la quale le mie idee resterebbero fogli sparsi. «Mauro, dobbiamo fare un libro con Erich von Däniken. Sarebbe il coronamento naturale del lavoro di entrambi».
Confesso: al primo minuto ho temuto la montagna. Erich non è solo l’autore di Chariots of the Gods: è l’uomo che sessant’anni fa ha lanciato un masso nello stagno dei dogmi accademici, quando ancora parlare di antiche astronavi significava bruciarsi la carriera.
Ci siamo incontrati a Interlaken. Mi ha aperto il suo archivio privato: migliaia di immagini, molti scatti oggi irripetibili perché quei siti sono chiusi, malamente ristrutturati o distrutti. «È tutto a tua disposizione», ha detto con la semplicità che solo i grandi possiedono.
In quel momento ho capito che Cieli in Fiamme non sarebbe stato un “libro in più”, ma una sintesi di due metodi: il mio, filologico e centripeto (parto dalla Bibbia in ebraico letterale); il suo, empirico, emotivo e centrifugo (parte dal terreno, dai rilievi, dalle domande senza filtro). Mescolare le nostre strade significava produrre una narrazione nuova: non un commento biblico, non un album di viaggio, bensì un ponte tra testo e pietra, tra filologia e polvere.

Un approccio quasi accademico (senza le catene del dogma)
Abbiamo scelto una struttura rigorosa: note, bibliografia, rimandi incrociati. Davide Bolognesi, senior editor di Tuthi edizioni, ha cucito tutto con pazienza certosina, uniformando stile e fonti. Il risultato? Un saggio che può stare su uno scaffale universitario ma che conserva il respiro divulgativo.
Per ogni affermazione indichiamo la fonte primaria:
- un versetto ebraico in traslitterazione;
- un paragrafo del Libro dei Morti;
- una tavoletta cuneiforme con numero di catalogo;
- un articolo peer-review su Nature che descrive un cratere di “vetro silicatico” compatibile con un’esplosione nucleare… salvo poi concludere che «non può essere» perché il sito è troppo antico.
Questo paradosso metodologico – riconoscere l’evidenza e negarla per pregiudizio cronologico – è il filo rosso che attraversa il libro. Erich ed io rispondiamo assertivamente: se le tracce coincidono con la descrizione di un evento ad alta energia, la scienza onesta deve almeno ammettere l’ipotesi, non scartarla del tutto “perché non si può”.
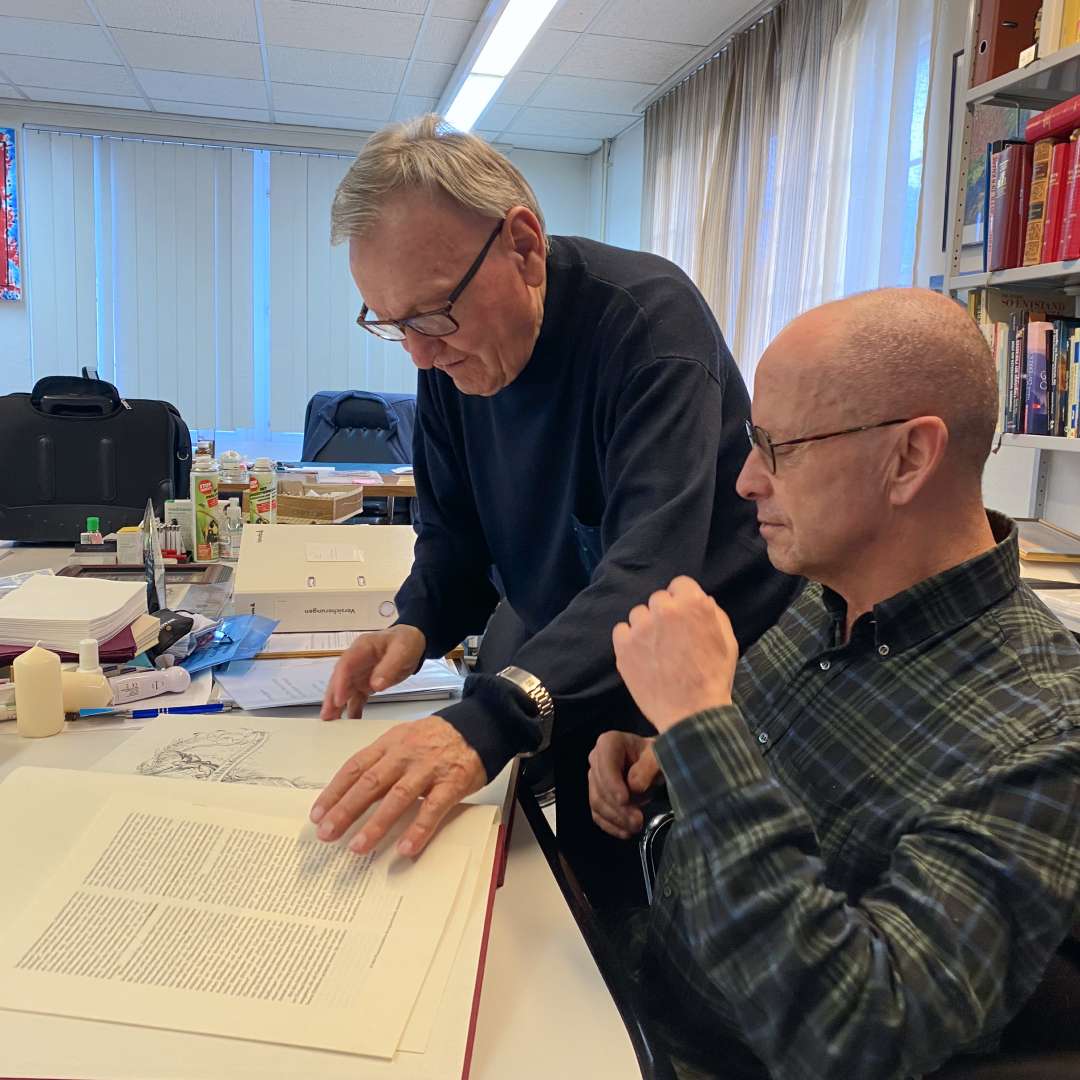
Dal centro alla periferia: perché smetto i vecchi paletti
Chi mi segue dal 2010 sa che mi ero imposto un recinto: «Parlo solo di Bibbia». Cieli in Fiamme rompe quel limite. Certo, troverete Abramo, Ezechiele, Salomone, il kavod che vibra e brucia. Ma subito dopo viaggerete in Etiopia con il Kebra Nagast, sulle rive del Gange a bordo dei vimāna, nella valle dei Dogon a decifrare il mistero di Sirio B.
Questa scelta nasce da un’evidenza empirica: tutte le culture arcaiche, dall’Africa alle Ande, raccontano lo stesso schema narrativo – esseri “celesti” che discendono avvolti da fuoco, nubi, terremoti. I segni sono omogenei persino nel lessico: i Sumeri parlano di ME “terribili”, gli Egizi di Ra che «illumina le tenebre con il suo fuoco», la Bibbia di un kavod che «dietro le sue spalle produce un grande rumore».
Se venti popoli, senza internet, descrivono il medesimo evento, l’ipotesi copiatura vacilla; prende corpo la pista della testimonianza convergente.

Sodoma, Gomorra e il “vento del male”
Uno degli esempi più potenti arriva dal Medio Oriente. In Cieli in Fiamme dedichiamo grande spazio ai resoconti sumero-accadici noti come Lamentazioni: testi che parlano di un “vento del male” capace di far vetrificare la pietra e disintegrare corpi. Non è fantasia: scavi nella valle del Giordano mostrano case polverizzate e ossa calcificate. Un team internazionale ha pubblicato su Nature l’analisi mineralogica: pattern identici a un’esplosione atomica. Tuttavia, con un atto di fede inversa, gli autori archiviano la spiegazione nucleare perché «troppo antica».
Noi facciamo un passo in più: mettiamo quei dati accanto ai versi biblici su Sodoma e Gomorra, alle cronache hittite di armi «che bruciano il cielo», alle tradizioni indiane sugli astra divini. Il quadro diventa coerente: nel passato remoto qualcuno possedeva dispositivi a energia colossale e li usò.
Essere consapevoli di questo precedente non è morbosità: serve a riflettere sull’attualità. Nel momento in cui scrivo, le cronache parlano di tensione nucleare tra Israele e Iran. Tre millenni sono ormai trascorsi, ma il teatro è lo stesso. Conoscere la storia serve, forse, a non ripeterla.

Tra ruach e portali: tecnologia descritta, non mitizzata
Uno degli scogli più grandi è la traduzione. Prendiamo ruach: vento? Spirito? Dipende dal contesto. Ezechiele usa ruach per descrivere il movimento del veicolo “grande”, e kavod per quello “piccolo” che decolla tra boati. Chi traduce kavod come “gloria” rischia il grottesco: la gloria di Dio con marmitta catalitica?
Stesso discorso per i palazzi-aerei del Bhāgavata Purāṇa: «viaggiavano come il vento, potevano sostare in orbita, avevano giardini, dormitori, sale da gioco». È una metafora spirituale o la descrizione, in lingua prescientifica, di un habitat orbitale?
Nel libro ipotizziamo un modello a doppio stadio: grandi navi interstellari, vere città celesti che restavano in orbita, e navette atmosferiche a combustione chimica per l’atterraggio. Lo stesso concetto spiegato da Erich con la metafora della portaerei: propulsione nucleare per l’oceano, tender o gommone a scoppio per la spiaggia.
Fisica del passato: gli atomi secondo gli antichi
Un capitolo che adoro titola «La fisica del passato». Cito la Vaiśeṣika Sūtra: «Due paramāṇu formano un aṇu; dalla loro aggregazione nascono gli oggetti». È chimica quantistica in sanscrito. Gli autori antichi non “giocavano” con termini spirituali: descrivevano la struttura della materia. Negarlo significa sottovalutare un patrimonio immenso.

I Dogon e Sirio B: cronaca di un incontro impossibile
Molti mi chiedono: «Perché inserire la tribù dei Dogon?». La risposta è nei fatti. Negli anni ’70, antropologi francesi raccolsero il mito di Amma, la stella compagna di Sirio, da popolazioni prive di telescopi. Oggi sappiamo che Sirio B esiste e ha una massa enorme.
Erich visitò il Mali quando i villaggi erano ancora aperti agli studiosi; scattò fotografie che pubblichiamo integralmente. Il racconto Dogon include dettagli precisi sull’orbita ellittica che la scienza confermerà decenni dopo. Coincidenza? Visione sciamanica? O retaggio di un antichissimo contatto “insegnato” dagli stessi viaggiatori stellari dei nostri testi sacri?
Coraggio e accademia: dialogo difficile, ma non impossibile
Durante la stesura dei testi ho avvertito un cambiamento. Molti giovani ricercatori, anche in ambito universitario, scrivono per dire: «Non possiamo ancora esplicitare certe ipotesi, ma leggiamo i vostri libri di nascosto». È un segnale confortante. Il progresso scientifico nasce da congetture da verificare, non dogmi da difendere.
Lo stesso Erich ricorda docenti di Maya-logia che ammettevano (off-record) l’esistenza di datazioni “stonate” rispetto alla cronologia ufficiale. Alcuni contributi di Cieli in Fiamme riportano proprio le dichiarazioni anonime di ricercatori che preferiscono restare nell’ombra. È triste, ma è già un passo avanti: la fessura esiste, la luce filtra.

Gli ultimi capitoli: dal “vento del male” alle stelle
Il cuore emotivo del libro, per me, sono gli ultimi tre capitoli.
- Il vento del male, rilettura filologica delle Lamentazioni sumere.
- Portali tra i mondi, analisi del Salmo 24 e del Libro delle Porte egizio; scopriamo formule quasi identiche – petachim le’olam e «apri cancello a Ra» – che parlano di varchi spazio-temporali.
- Verso le stelle, un’ode al futuro: guardiamo in alto, come Galileo, e ci chiediamo se noi, figli di antichi “maestri spaziali”, saremo capaci di varcare a nostra volta quei portali.
Chiude il volume una riflessione sulla responsabilità del sapere: conoscere la potenza delle armi antiche e la saggezza di chi, forse, ci accompagnò fin qui dovrebbe renderci più umani, non più arroganti.
Domande frequenti su Cieli in Fiamme
«È un libro di fantascienza?»
Assolutamente no. È un saggio che utilizza criteri storici comparativi. Le ipotesi sono audaci, ma le fonti sono reali, citate e verificabili.
«Devo conoscere l’ebraico o il sanscrito per capirlo?»
No: inseriamo la traslitterazione originale e subito la traduzione letterale, spiegando ogni termine chiave. L’apparato è pensato per il lettore curioso, non per lo specialista.
«Che differenza c’è con i tuoi libri precedenti?»
La principale è la vocazione “globale”: non più solo Bibbia, ma una costellazione di testi e reperti dislocati in cinque continenti, letti alla luce di un metodo filologico-archeologico integrato.
«Ci sono foto inedite?»
Sì, oltre cinquanta scatti provenienti dall’archivio personale di Erich: Yemen prima delle guerre, templi nubiani ora sommersi, interni di Petra visitabili solo ai ricercatori negli anni ’70.
«Posso usare il libro per una tesi universitaria?»
Molti laureandi lo stanno già facendo. Le nostre note rimandano a pubblicazioni peer-review, codici di tavolette cuneiformi, registri museali. Il materiale è pronto per un uso accademico serio.
Perché leggere Cieli in Fiamme adesso
- È un ponte tra approccio filologico e lavoro sul campo.
- Offre fonti verificabili: note e bibliografia estese, non slogan.
- Parla al presente: le guerre di oggi echeggiano i conflitti di ieri, ricordandoci che la posta in gioco è sempre la stessa – la sopravvivenza, la memoria, il cielo.
- Accende la curiosità: chi ama la scienza troverà dati da indagare; chi cerca spirito troverà domande sulla nostra identità cosmica.
- È coinvolgente: pagina dopo pagina, sentirete la voce di chi ha visto – Erich – e di chi ha tradotto letteralmente – io.
Conclusione
Scrivere Cieli in Fiamme mi ha cambiato profondamente. Mi ha costretto a smontare i miei stessi paletti, a guardare la Bibbia non più come un’isola ma come parte di un arcipelago narrativo globale. Ha rafforzato la convinzione che la storia umana è più lunga, più intricata, più elettrica di quanto ci abbiano insegnato e ancora oggi ci insegnano.
Se avete letto fino a qui, grazie di cuore. Continuate a cercare, a dubitare, a porre domande. Solo così, forse, un giorno, alzeremo lo sguardo e vedremo quei cieli in fiamme non con timore, ma con la meraviglia di chi riconosce finalmente il proprio posto tra le stelle.
A presto, Mauro
Un ultimo invito
Se amate la ricerca libera, condividete questo articolo, commentate sul blog, fate girare le vostre intuizioni. Ogni discussione è un mattone in più nel ponte che ci porterà – ne sono sicuro – a riscrivere insieme la nostra storia.





